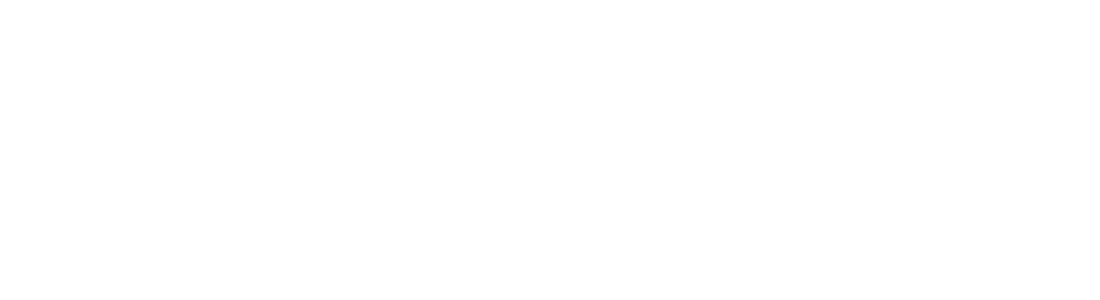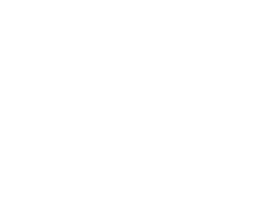Allegoria e immagini della morte in Alfred Döblin
Due racconti giovanili di Alfred Döblin
di Giuseppina Pagliafora
«La morte […] una delle due grandi contraddizioni della vita».
A. Döblin
«La morte è lo specchio in cui il nostro spirito si contempla: la morte è il riflesso, l’eco del nostro essere».
L. Feuerbach
«Non c’è nulla che ci faccia più paura di vedere, per caso, in una notte di luna il nostro volto riflesso in uno specchio».
H. Heine
Il contributo che mi accingo a presentare nasce come ulteriore analisi di una mia personale curiosità sviluppatasi intorno al volume L’assassinio di un ranuncolo e altri racconti di Alfred Döblin[1]. Un interesse che affonda le proprie radici nella convinzione che questi scritti, ad una lettura critica più accurata, possano apparire non solo degni di essere esaminati e di guadagnare una più ampia diffusione[2] ma al tempo stesso permettano la nascita di un punto di vista critico “diverso” sul ritratto dell’autore.
Approfondendo l’analisi dei racconti del ciclo della Butterblume, si scorgono accato a narrazioni stridenti, dissonanti, per le metafore che offrono al lettore, altri più brevi, silenziosi, meno invadenti, per certi aspetti “acerbi” eppure tanto più ricchi nella loro apparente essenzialità. Qui Döblin afferma il rifiuto di qualsiasi forma di psicologismo, considerato come «un dilettantesco esercizio di supposizioni, chiacchiere scolastiche, pomposo almanaccare, lirica finta, inutile»[3]. Certamente, in questo senso i racconti svelano un certo gusto naturalistico, sembrano essere costruiti in quello “stile di pietra” di cui Döblin fa professione nel Berliner Programm (Programma Berlinese, 1913), ma la maschera che Döblin pone per “necessità” sui suoi personaggi non è niente di più che un camuffamento per la mistificazione di una quotidiana normalità; uomini e donne “della porta accanto”, borghesi, ballerine, tranquilli commercianti, militari, un universo che non stenteremmo a definire reale tanto più che la loro apparente normalità si stravolge ancorandoli al pathos.
Si potrebbe certo obiettare che questi racconti mancano del livello di complessità dei grandi romanzi, (il gusto döbliniano per l’esperimento lo ha portato a tentare diverse strade, con risultati che non sempre sono stati giudicati apprezzabili) tuttavia, in essi è già ravvisabile in germe la peculirità del futuro autore di Berlin Alexanderplatz (1929), per citare emblematicamente, e non rendendo merito agli altri scritti, l’opera a cui sovente si associa il nome dello scrittore berlinese. Visti pertanto nel contesto della genesi dell’imponente opera di Döblin, questi scritti hanno un loro rilievo e una propria omogeneità in quanto mostrano l’insistenza con cui l’autore si sofferma su quei particolari “nuclei di senso”, punti che si presentano come “costanti” e che poi, come abbiamo detto, si dischiuderanno, in tutto il loro valore nelle opere di maggiore spicco, con effetti amplificati dovuti ad una tangibile maturità stilistica.
Solamente dopo un’accurata rilettura dei personaggi e dell’impianto strutturale dei racconti, sul quale incombe per importanza L’assassinio di un ranuncolo, si dipana il sottile filo conduttore che, sia in maniera esplicita che meno vistosamente, celato sotto le spoglie della riflessione filosofica o della teoria e della critica letteraria, sottintende come prefigurazione la compagine narrativa döbliniana, ciò che Döblin sosteneva essere «una delle grandi contraddizioni della vita»: il senso di morte. Lungi dal voler interrogare l’autore su quale sia, a questo punto della riflessione, l’enigma riguardante “l’Altra” grande contraddizione della vita, intendo sottolineare che il senso di morte, che accompagna qualsiasi autore “autentico” durante il periglioso cammino della sua produzione di parole, è in primis quel “passo al di là” che Blanchot indica nell’atto stesso della scrittura. Döblin, nello scriversi è dunque il primo a morire.
Questo aggirarsi nei dintorni della morte emerge in Döblin a partire da un’urgenza che sicuramente risale ad una memoria individuale, ad un vissuto che filtrato dalla spiccata sensibilità artistica potremmo definire come sofferto e con tutta ragionevolezza subito. «Qui bisogna descrivere cosa è il dolore»[4] scrive Döblin nelle ultime pagine di Berlin Alexanderplatz e, mentre rende chiara questa sua esigenza al lettore, fa scivolare pian piano Franz Biberkopf in una «morte benigna»[5].
Gli scritti che esamineremo in questa occasione – Das Stiftsfräulein und der Tod (La signorina dell’ospizio e la morte, 1908) e Die Helferin (L’Aiutante, 1911) – si muovono, dal punto di vista dell’economia del racconto, in direzioni opposte e tuttavia parallele: il primo inizia con una vita che viene chiamata alla morte dalla morte stessa, mentre nell’altro racconto, L’Aiutante, viene narrata la vicenda di una fanciulla morta, uno spettro, un fantasma che assume le sembianze di un impiegato di una ditta di pompe funebri, resuscitato dal nulla dalla morte che lo aveva preso a sé, diventandone l’aiutante.
Tempo del soggetto e tempo della morte
«Quando nella notte la luna comparve dietro le tende della sua finestra, il letto della signorina traballò. Le sue dita s’aggrapparono ai due spigoli; tremante ella si strinse al giaciglio; verso il mattino sovente si lamentò. Oh, la massa informe piagnucolò, raggomitolata sotto le coperte e s’addormentò solo quando fu chiaro»[6].
Con questa descrizione nel breve racconto Das Stiftsfräulein und der Tod[7] viene introdotta nella vicenda di un’anziana signora, ricoverata in un ospizio, una signorina[8] o «zitella», come viene più volte definita alludendo senza dubbio alla sua acerbità nelle questioni della vita, l’immagine della morte, anello di congiunzione tra i dodici racconti che costituiranno il successivo ciclo Die Ermordung einer Butterblume. La consapevolezza della morte che viene acquisita dall’anziana signora semplicemente «seguendo con lo sguardo i liquami nerastri»[9] – la neve sporcata dai passi che nel giardino davanti alla sua finestra si scioglie al sole – non avviene in modo repentino, all’inizio del racconto si legge solo che ella comprende «all’improvviso che presto sarebbe morta»[10]. Seguendo i canoni tradizionali dell’immaginario secondo cui la morte “chiama a sé” la propria vittima, la morte dunque si annuncia, “fa visita” alla donna più volte durante le notti che seguono fino al momento della dipartita finale.
Così come il protagonista del racconto Die falsche Tür ( La porta sbagliata, 1911) viene guidato dal proprio Kismet[11] dal proprio «destino ineluttabile» che lo conduce appunto alla morte, anche la signorina dell’ospizio viene attirata verso il proprio destino, nella sua stanza come se «qualcuno»[12] la spingesse «oltre la soglia»[13], verso il luogo simbolico, metamorfico della morte. Lì, finalmente sola, comprende dai segni intellegibili emanati dalle cose intorno a sé di dover fare i conti, o meglio, di doversi arrendere, come sottolineato dal «lungo, stupido, ostinato pianto»[14], al proprio destino scandito significativamente dagli orologi che «nella notte ticchettavano […] nella sua stanza»[15].
La simbologia dell’orologio come monito dello scorrere della vita può apparire a prima vista una trovata narrativa alquanto retriva, anche se adeguata. In Poe, per citare solo un esempio, l’arrivo della pestilenza, della “morte rossa“, che nel racconto omonimo viene esorcizzata tramite l’organizzazione di una magnificente festa da ballo in maschera, viene ricordata ai cavalieri e alle dame della corte di re Prospero proprio da una pendola:
In questa sala si trovava pure, appoggiato contro la parete, un gigantesco orologio d’ebano. Il suo pendolo emetteva un suono cupo e monotono e quando la lancetta dei minuti compiva il giro del quadrante e batteva l’ora, veniva fuori dai suoi polmoni di bronzo un suono chiaro, forte e profondo, straordinariamente musicale ma di una tale forza, che ad ogni ora i musicisti dell’orchestra erano costretti a fermare l’esecuzione dei loro pezzi, per ascoltare quel suono; e così anche le coppie interrompevano le danze e su tutta l’allegra compagnia cadeva un velo di tristezza; e mentre l’orologio scandiva ancora i suoi rintocchi si notava che i più spensierati impallidivano e i più vecchi e sereni si passavano una mano sulla fronte in un gesto di confusa visione o meditazione[16].
Ma tale motivo, nel racconto di Döblin, assume connotati differenti; mentre infatti in Poe i rintocchi del pendolo hanno un suono grave, cadenzato nella loro monotonia e riescono a far “meditare”, impallidire anche i convitati più sereni e spensierati in un meccanismo tipico di una logica horror, gli orologi che nel nostro racconto scandiscono il tempo e, come in Poe ne annunciano l’approssimarsi, sono due; così stabilendo una “sincronia”, una consonanza con lo stato d’animo, l’atteggiamento della signorina verso il proprio decesso, pur parlando entrambi di morte hanno un “comportamento” diverso di fronte ad essa. Vediamo come viene introdotta l’immagine. Döblin parla di una stanza in cui su una parete sono appesi due orologi:
Uno inghiottiva pacifico il tempo e belava ogni mezz’ora, poi si saziava, ma continuava a ruminare; accanto chiocciava l’orologio a cucù, trasaliva, non si dava respiro, e quasi si strozzava quando emetteva il suo miserabile strido. La signorina balzò dal letto e arrestò il pendolo. Mentre giaceva di nuovo immobile, nell’orologio piccolo ci fu un sussulto e il volto di quello grande si contrasse in un sogghigno[17].
Soffermiamoci per un momento su questo frammento, a mio parere assai significativo, entriamo all’interno di una possibile metafora celata da Döblin: due orologi con due divrse modalità di scansione del tempo offrono al nostro sguardo due possibili interpretazioni.
La prima via ci conduce sul sentiero di Edipo, freudianamente parlando. Proviamo a dimenticare per un solo momento che stiamo parlando di orologi e lasciamoci trasportare dalle immagini create dalla penna di Döblin: un orologio che come un poppante “inghiotte pacifico” e “belando” si sazia “ogni mezz’ora” pur continuando a “ruminare”, l’altro che “chioccia”, accudisce, veglia ma al tempo stesso “trasale”, “stride miseramente” in un moto che potremmo definire come isterico. Trasportando questa rappresentazione al vissuto di Döblin non si può non supporre il rapporto particolare che ha legato l’autore alla madre, soprattuttto dopo l’abbandono della famiglia dello scrittore da parte del padre, come testimoniato in Senza quartiere (1935), “piccolo romanzo berlinese”, cronaca familiare dagli spiccati tratti autobiofrafici. L’altro percorso, invece, riguarda i tempi del soggetto: sempre l’artista Döblin rimanda, attraverso la laconica registrazione di un sintomo esterno, alle complesse vicende interiori da cui scaturisce. Come suggerisce Banchelli, «i protagonisti di Döblin […] sono colti tutti, senza eccezione, nell’istante in cui la loro supposta normalità si stravolge in patologia, il faticoso, precario meccanismo di difesa si inceppa»[18]. Così, il soggetto scisso davanti ad un reale che per la prima volta chiama la signorina per mezzo della morte è metaforicamente simboleggiato dai due orologi: uno che inghiotte e si “sazia” e l’altro che tenta di opporre resistenza, come dimostrato dalla descrizione con cui Döblin completa l’immagine dei due orologi: «La signorina balzò dal letto e arrestò il pendolo»[19], testimonianza, questa che dimostra come la metafora döbliniana finisca sempre irrimediabilmente con l’implicare il soggetto uomo al di là di ogni sua esplicita intenzione.
Cosa accade dunque nella signorina quando ansimante, con urlante lucidità, con gli occhi serrati esclama «devo morire, devo morire»?[20] Come spiega Morin, l’individualità umana «è la solo a mostrarsi lucida di fronte alla morte, a patirne il trauma. […] Questa lucidità d’altronde non è la presa di coscienza di un sapere caratteristico della specie ma frutto di un sapere strettamente individuale: l’individuo si appropria della coscienza della morte che non è dunque innata, ma rappresenta una conquista della coscienza ormai in grado di cogliere il reale»[21].
Ma la signorina non si mostra lucida di fronte alla coscienza della morte, ciò risulta tanto più evidente poiché il quadro della realizzazione della morte ci riporta ad una dimensione che induce a pensare ad uno smarrimento, al bisogno di ritrovare sicurezza fino a sfociare nell’infans:
Ella si gettò addosso i vestiti, uscì, raggiunse il parco […] In piedi vicino all’acqua fumante nelle prime luci dell’alba, fissava davanti a sé con sguardo tremulo. S’immerse ansante ed urlante, gli occhi serrati in uno spasimo, batté le manine scarne sull’acqua, poi, improvvisamente, si voltò e fuggì a casa tra gli alberi neri[22].
Il reale di cui parla Morin potrebbe dunque essere concettualizzato da Döblin con quella natura che si manifesta sia “nell’organico che nell’inorganico” come suggerito dalle idee che comporranno il saggio Das Ich über die Natur (L’Io al di sopra della Natura, 1927) pubblicato solo negli anni Venti e poi confluito nel volume Unser Dasein (Il nostro Esserci, 1933). Stegemann, nell’acuta naalisi delle metafore presenti nei racconti dell’Assassinio di un ranuncolo, definisce i racconti giovanili di Döblin come variazioni sul tema Io-Natura, individuando di volta in volta una diversa chiave di lettura del rapporto tra individuo e mondo-natura. Secondo questa interpretazione il racconto La signorina dell’ospizio e la Morte altro non sarebbe che l’esemplificazione di come l’Io, pur lottando con tutte le proprie forze contro la morte – intesa come componente necessaria della natura – debba in ultima analisi soccombere innanzi alla sua potenza[23]. In questi saggi, che vanno visti come un tentativo da parte di Döblin scrittore e al tempo stesso psichiatra di fare chiarezza sulla propria fede, di dare forma a un sentimento di religiosità che si scontrava con le letture filosofiche e il percorso di uomo di scienze intrapreso dall’autore, di dare «una risposta ai molteplici dubbi, “classici” per la sua generazione, circa la validità dell’approccio sciantifico-positivista alla comprensione di un reale che […] minacciava di sommergere al vita e l’arte in una pericolosa ondata di irrazionalismo»[24] è evidente l’influsso di Feuerbach, di Spinoza e di Goethe come pure di Hölderlin. Ma a ben guardare, tali interrogativi sono mossi anche dalla volontà di far luce su un’esperienza davanti alla morte che se non in prima persona Döblin si è trovato ad affrontare numerose volte come medico e, non è azzardato supporre, di dare una risposta seppure con gli occhi dello scettico all’eterno interrogativo «was ist Gott?»[25] «cos’è Dio?», come domanda antica, risalente all’infanzia circa il significato e il senso di una religiosità che Döblin bambino, membro di una famiglia ebrea, sentiva come scomoda ma affascinante nel proprio mistero[26]. Il saggio Das Ich über die Natur si concludeva con una serie di precetti, di Leitsätze, che riassumevano il concetto di Ur-Ich, come sostanziale unità tra Io e Natura. Qui egli scrive:
Ciò che nella natura appare come essere animato, esercita dappertutto un influsso vivo come ordine, numero, leggi matematiche, […] e mostra in tal modo la sua origine da un senso e da uno spirito originario, e la sua posizione in tale spirito. Questi è attivo anche in noi, esseri capaci di sentire e progettare. Con questo legame siamo preservati dallo scomparire nella natura. Qui anche la distruzione, l’andare in rovina, la trasformazione non è nulla. Tutto diventa qualcosa solo grazie al suo significato. E in generale non è la natura dinamica, fisica, chimica, spaziale-temporale a conferire realtà ed esistenza alle cose, bensì solo il nesso con il senso originario con l’Io originario[27].
L’anziana signora acquista dunque coscienza della propria morte e in una paradossale “beatitudine” di fronte alla morte abbraccia per la prima volta la vita solo nel momento in cui si appresa a lasciarla. Il suo atteggiamento sembra essere quello di Claudio, protagonista del dramma di Hofmannsthal Der Tor und der Tod quando afferma «Da tot mein Leben war, sei du mein Leben, Tod!»[28].
L’antropomorfizzazione della morte consente a Döblin di evidenziare un altro aspetto: la metafora erotica. L’identificazione della morte con il sesso maschile che nella traduzione italiana viene irrimediabilmente perduta, dando luogo a non pochi fraintendimenti, erompe in tutta la sua forza nel testo originale proprio perché il sostantivo tedesco Tod, come fa ben notare Banchelli, Döblin di evidenziare la natura sensuale dell’attrazione tra la signorina e il suo sinistro partner»[29].
Scrive Bataille, «dell’erotismo si può dire, innanzitutto che esso è l’approvazione della vita fin dentro la morte»[30], ecco dunque che l’accettazione della morte sfocia in un istinto vitale chee assume i connotati di una lotta[31] per la sopravvivenza:
Con un balzo la morte s’infilò accanto a lei […] ella cercò di difendersi. Come uno zoticone la morte le affibbiò qualche manata sulle spalle. Ed ecco che il suo pugno s’abbatté sul petto, sul corpo di lei, ancora, ancora e ancora. Le labbra della donna implorarono. Venne una stretta soffocante. La lingua ricadde indietro nella gola. Ella si tese. Allora la morte s’alzò e afferrò per le fredde manine la signorina dell’ospizio dietro di sé, attraverso al finestra[32].
La doppia faccia della morte: l’angelo e la bestia
Mentre in Reseverkehr mit dem Jenseits[33] (Traffici con l’aldilà, 1944), una sfrenata clownerie, come la definì lo stesso Döblin, il mondo dei defunti, l’aldilà ci viene presentato in maniera scherzosa come una pittoresca comunità che introduce il caos nelle indagini per la morte del protagonista, il birraio van Steen – morto che non sa di essere morto, convinto com’è di essere partito per un viaggio e di trovarsi semplicemente «altrove»[34] – nel racconto Die Helferin il protagonista, l’aiutante, Mike Bondi nasconde una doppia identità oltre che un oscuro passato.
Mike Bondi, nell’apparato narrativo iniziale, è un impiegato che «al momento dell’assunzione doveva avere circa vent’anni»[35] e che nel corso dei quindici anni di occupazione presso l’azienda del sig. Grasso si distingue per l’immutabilità del «suo viso da fanciullo»[36]. Intorno alla vita e al passato di Bondi aleggia un velo di mistero, nessuno sa da dove provenga né dove vada a dormire, nessuno dei suoi conoscenti potrebbe neppure descrivere i suoi occhi «poiché nessuno li ha mai visti»[37]. Nondimeno il personaggio di Mike Bondi possiede all’inizio della narrazione una valenza positiva dato che il periodo di fioritura della ditta del signor Grasso, paradossalmente un’impresa di pompe funebri, coincide con la sua assunzione e, cosa più importante, questo strano personaggio porta, per mezzo della parola, la pace ai morenti. In compagnia di un fedele compagno, un altrettanto «silenzioso» levriero bianco, Bondi si reca nelle case dei malati, dei sofferenti, e parla con loro, portando una serenità e una pace tali che questi «gli erano riconoscenti per i minuti che aveva riempito loro con qualche parca parola. Quelli che avevano avuto la sua visita, diventavano più calmi, smettevano di soffrire, ma morivano tutti»[38]. Dal racconto non ci è dato di sapere la sostanza del dialogo, di lui sappiamo che per inclinazione personale dice di cose «semplici e realistiche», che parla «molto poco» e oltre che dei suoi affari, «solo d’alberi, di radici, di campi e d’animali, per i quali di solito gli abitanti delle città nutrono scarso interesse»[39]. Döblin non fa luce su questo punto, sulle parole pronunciate dall’aiutante ai malati cui fa visita, ma appare subito chiaro che la cura che il «minuto» impiegato dall’«andatura furtiva» contrappone alle sofferenze dei degenti non è la terapia della scienza né quella della fede tanto è vero che «i malati lo facevano chiamare prima ancora del prete o del medico»[40] e, come risulterà poi dalle indagini processuali, «egli non s’avvicinava loro, non dava loro nulla, non li toccava»[41]. Potremmo dunque supporre che le parole che egli pronuncia siano qualcosa di diverso, di straordinariamente potente dato che riescono a mitigare la paura per ciò che maggiormente crea angoscia al genere umano: il pensiero della morte.
In un romanzo di poco precedente la stesura del racconto in esame, Der schwarze Vorhang, (pubblicato su «Sturm» nel 1912 ma concepito tra il 1902 e il 1903) La cortina nera nella traduzione italiana, il cui sottotitolo recita Romanzo delle parole e delle casualità, Döblin fornisce fin dall’inizio un indizio prezioso riguardo al contenuto del romanzo stesso: le parole consolatorie che Johannes, il protagonista, rivolge alla propria amata ormai in punto di morte:
In seguito si ammalò gravemente. Egli non sapeva trovare la via per arrivare a lei. Fu allora che ella, prossima alla morte, lo fece chiamare. Lei gli chiese inquieta cosa sarebbe stato di lei dopo la morte. Distrutto egli raccontò del nascere e del morire. Tutto sarebbe terreno in loro, ma sarebbero rimasti sempre sulla terra, perché nella terra tutto si dissolve per ricrescere ancora, nuovamente, nella pioggia, nella luce del sole, nella neve, nell’indifferenza, nell’odio, nella gioia e nel dolore e nell’amore[42].
Johannes parla dunque di un eterno nascere-divenire (Werden) e tra-passare (Vergehen), diremmo noi, riprendendo un concetto espresso da Döblin nel saggio Das Ich über die Natur, di quella Umformung, costante trasformazione che regola la vita degli esseri animati e inanimati, della natura “terrena” quindi caduca degli esseri viventi ma anche di una ulteriore permanenza sulla terra dove tutto si “dissolve” e si “annulla” («in der Erde löse sich alles auf») per ricrescere negli elementi primigeni della natura stessa:«pioggia, sole neve», come pure nelle passioni/pulsioni opposte che regolano la vita: «odio, felicità, dolore, amore». Con Blanchot diremo allora che ciò che si evince da questo frammento è che chi muore «non rinuncia a vivere, chiude soltanto gli occhi»[43]. Se siano davvero queste le parole con cui l’impiegato Mike Bondi infonde pace agli agonizzanti è una questione che rimane irrisolta, ma un’ulteriore conferma ci potrebbe pervenire da quella raccolta Vom Leben und Tod (Della vita e della morte, 1955) dettata dallo scrittore ormai anziano e malato dal suo letto d’ospedale. In essa, nonostante il passaggio per la conversione alla fede cattolica, non si può parlare di una completa sconfessione delle precedenti posizioni legate per molti versi alle rappresentazioni panteistiche e alla considerazione della natura, della sua forza e della sua bellezza. Alla fine dei suoi giorni, Döblin non finisce di ammirare la bellezza del creato, simboleggiata dalla maestosità di un albero. Il nucleo della sua trattazione non è più, o solamente, Dio, ma lo stupore e l’ammirazione di tutti gli esseri animali e vegetali; «la morte appare allora allo scrittore come la conclusione di un ciclo vitale, una tappa nel continuo rigenerarsi della natura, in cui morte e vita sono un’unica cosa, dunque non “esistono”, almeno nella normale considerazione che l’uomo mortale ha delle cose»[44].
Nel corso della narrazione si viene a scoprire che in realtà Mike Bondi è una giovene morta all’incirca ottanta anni prima di un male incurabile: la morte l’aveva strappata alla vita concedendole di diventare la sua aiutante. Cos’è che consente a Bessie Bennet, questo il nome della giovane defunta che si nasconde dietro le sembianze del pacifico Mike Bondi, di continuare a vivere oltre la morte? Se ci limitassimo a considerare la seconda vita della giovane come legata semplicemente alla metempsicosi non ci sarebbe nulla di anomalo dal momento che già «nelle coscienze arcaiche in cui le esperienze elementari del mondo sono fatte di metamorfosi, sparizioni, riapparizioni e trasformazioni ogni morte annuncia una nascita, ogni nascita deriva da una morte, ogni cambiamento corrisponde a una morte/rinascita e il ciclo della vita umana è inscritto nei cicli naturali della morte/rinascita. La concezione cosmomorfica primitiva della morte», continua Morin, «è dunque quella di una morte/rinascita; secondo tale concezione il morto, prima o poi rinasce sotto le sembianze di un nuovo essere vivente, bambino o animale che sia»[45].
Ma la morte della giovane non prelude ad una rinascita, Bessie è e rimane morta ma è morta per metà, così come vive in una dimensione a metà tra la vita e la morte[46], di giorno come il mite impiegato Mike Bondi e di notte come spettro seppure entrambi al servizio della morte. Da «cadavere in un corpo vivente»[47], aiutante della morte, benefattrice di coloro che con dolore si apprestano a lasciare la vita, Bessie Bennet serve paradossalmente la vita stessa, tanto che sarebbe più esatto parlare di una pulsione di morte nel senso freudiano del termine.
La morte possiede, per mezzo della sua aiutante, una corporeità, uno strumento per agire ed entrare in contatto con le proprie “vittime”. In questo senso esiste una totale simbiosi tra la morte e la sua aiutante, il mezzo attraverso cui agisce. Scrive Döblin: «Ella [la signora Grasso] chiuse gli occhi, e quando tornò a sollevare le palpebre, non vide più Mike Bondi. Ma, là dov’egli erapassato, c’era ora nell’oscurità un bianco chiarore, uno scheletro curvo avanzava silenzioso, la morte in persona camminava con passo strascicato»[48]. Döblin insiste sulla doppia natura della morte che viene percepita e considerata in maniera tanto diversa dagli esseri viventi, come spettro contro cui lottare o come morte benevola amica liberatrice dalle sofferenze; come sottolinea anche Blanchot «poiché la morte è ciò a cui non siamo abituati, ci avviciniamo ad essa sia come all’inabituale che meraviglia, sia come al non familiare che fa orrore»[49]. Proprio come Franz Biberkopf quando innanzi alla «morte benigna che pone fine a tutto […] trema quando la sera si tira più su nel letto per riceverla»[50].
La scoperta della verità, della reale identità di Bondi avviene in maniera del tutto casuale: la moglie del signor Grasso, sospettando un tradimento, segue il marito nottetempo constatando che la presunta rivale in amore in realtà è uno spettro, una morta.
Davanti alla bara in cui era balzato lo spettro, l’omone [il signor Grasso] si prostrò; due braccia bianche si tesero verso di lui; indietreggiando inorridita, ella vide la giacca aperta e i due piccoli seni verginei tra i quali affondò un volto rugoso, madido di sudore. Vide sollevarsi il muto viso da fanciulla di Mike Bondi, vide, fuggendo verso la porta, che Mike attirava a sé con tenere parole d’addio l’uomo distrutto e che i due si abbracciavano[51].
Il processo che segue alle indagini vede la folla come impazzita scagliarsi contro la «svergognata»[52], la «diabolica avvelenatrice»[53], giudicata dalla calca accorsa per assistere al verdetto come la colpevole della morte dei malati cui faceva visita, in una pochezza tipica dell’individuo döbliniano – «borghesi trincerati in un’ottusa corazza di filisteismo e repressione del proprio slancio vitale»[54], slancio di cui la morte è in questo racconto appunto l’emblema. Quella solita ottusità che sul finire di Berlin Alexanderplatz sembra anticipare una sorta di frastuono ordinato e marziale che poi andrà a scandire tutta la successiva, catastrofica storia della Germania nazista: «Segnate il passo, sinist, dest, sinist, dest, marciare, marciare, andiamo alla guerra, e cento suonatori marciano con noi, con trombe e con tamburi, tarabum bum bum, chi marcia e chi cade, chi vive e chi muore, tarabum bum bum, tarabum, bum bum bum»[55].
Innanzi all’insensatezza della folla, «la morte benigna», l’angelo apportatore di serenità mostra l’altra sua faccia, si getta con ira contro quella folla di cui era stata silenziosa, fedele complice:
Un senso di soffocamento serrò il petto di tutti i presenti. Uno di loro sfondò ansante la finestra, ma l’aria fresca non gli diede sollievo […] per un istante regnò nell’aula l’antico silenzio, interrotto dal tonfo di corpi che cadevano. La ragazza dai neri capelli lasciava vagare i grandi occhi spalancati. Le usciva di tra i denti un sibilo acuto e furioso. Un uomo entrò barcollando nella sala, le afferrò un braccio. Elle gli sfiorò i capelli, soffiò contro i suoi piedi; le fiamme avvamparono su di lui; con grida roche egli indietreggiò incespicando, si schiantò al suolo. La ragazza dai neri capelli s’era piegata su se stessa. Si rialzò, sfiorandosi le tempie ritta in mezzo all’ampia sala avvampò in una nera fiamma verso il soffitto, salì in una colonna di fumo oltre la casa[56].
L’immagine che trapela da questa descrizione è quella di un’ulteriore morte-rinascita, che a tratti assume toni apocalittici e ricorda il mito della fenice che si rigenera dalle proprie ceneri. La colpa degli uomini che nella loro ottusità non hanno compreso, che hanno rinnegato e mostrato astio invece di comprensione per il “mistero” legato alla morte benevola, alla sua aiutante, viene “purificata” per mezzo delle fiamme. La vendetta della morte apportatrice di serenità si compie attraverso una morte orrifica: «circa seicento persone, donne e bambini, morirono bruciati»[57].
La favola, come la definisce Döblin nell’ultima descrizione del racconto, abbandona la propria connotazione di leggenda per assurgere ai connotati del mito: «da quel momento non si vide più la morte benigna aggirarsi per le strade, seguita dal suo enorme levriero bianco che camminava silenzioso come lei, guardando intorno a sé con occhi vuoti»[58]. Così come nella conclusione del racconto La signorina dell’ospizio e la morte, la morte si manifesta come qualcosa di brutale, di violento che afferra le proprie vittime, le “azzanna”, per portarle via con sé, per «trascinarle […] dietro di sé»[59]: «Ma pare che alcuni ammalati abbiano raccontato nei loro deliri che il bianco animale balzava scatenato sul loro petto, li terrorizzava con i suoi occhi vuoti, piantando i lunghi dentacci nella loro gola»[60].
Note
[1] Mi permetto a tal proposito di rinviare a G. PAGLIAFORA, Metafora e simbolo. Riflessioni su “L’assassinio di un ranuncolo” di Alfred Döblin, in «Parénklisis», 2005, 3, pp. 79-92.
[2] Della copiosa produzione letteraria di Döblin esiste in traduzione italiana solo una minima porzione; e, anche di questa, è disponibile solo una parte esigua dato che alcuni volumi, incanalati purtroppo in una logica di mercato, sono oramai “fuori catalogo”. Un impegno in questo senso è quello assunto dalla IADG (internationale Alfred Döblin Gesellschaft) che da molti anni mette insieme gli sforzi di studiosi e ricercatori col comune fine di valorizzare e diffondere l’opera dello scrittore berlinese.
[3] Comparso sulla rivista «Der Sturm», n. 158-159 del maggio 1913 e ora in A. DÖBLIN, Aufsätze zur Literatur, Olten u. Freiburt/Br, Walter 1989, pp- 15-19.
[4] A. DÖBLIN, Berlin Alexanderplatz, Milano, Rizzoli 2001, p. 486.
[5] A. DÖBLIN, Ibidem.
[6] A. DÖBLIN, La signorina dell’ospizio e la morte, in A. DÖBLIN, L’assassinio di un ranuncolo e altri racconti, Milano, Sugarco 1980, p. 42.
[7] Il racconto fu il primo, di quelli che costituiranno il successivo volume Die Ermordung einer Butterblume, ad essere pubblicato da Döblin nel 1908 per la rivista mensile fondata da Walden «Das Magazin». In realtà il racconto risale al 1905, ovvero al periodo dei suoi studi post-universitari sui «Disturbi della memoria nella sindrome di Korsakoff» presso l’università di Friburgo. (cfr. AA. VV., Alfred Döblin 1878 – 1978. Eine Ausstellung des Deutschen Literaturarchivs im Schiller-Nationalmuseum Marbach am Neckar, Marbach, Deutsche Schillergesellschaft 1978, p. 14).
[8] È significativo che in molti dei racconti di Döblin i personaggi non abbiano un nome che li identifichi o che esso sia presentato solo in un secondo momento come a voler significare che al di là della vicenda personale narrata dal racconto stesso ciò che interessa veramente è la vicenda in sé, in un tentativo di assolutizzazione e generalizzazione dell’oggetto della narrazione. Santoli riconduce questo aspetto tra il teatro medievale e l’espressionismo, il quale ripresenterebbe in chiave moderna modi costruttivi dei «misteri medievali […] sostituendo al personaggio che ha un nome proprio un personaggio dal nome comune. V. SANTOLI, La letteratura tedesca moderna, Milano, Rizzoli 1993, p. 329. Diversa la posizione di Mittner secondo cui il personaggio senza nome deriverebbe «più che dall’efficacia del dramma medievale allegorico e del Jedermann di Hoffmannsthal, dallo Sconosciuto di Strindberg». L. MITTNER, Storia della letteratura tedesca. Dal realismo alla sperimentazione: dal fine secolo alla sperimentazione, Torino, Einaudi 1971, vol. II, p. 1194.
[9] A. DÖBLIN, La signorina dell’ospizio e la morte, cit., p.41.
[10] Ibidem.
[11] La parola, in turco nel testo originale, deriverebbe dall’arabo qismat o qisma nel senso di “divisione, ripartizione” che presso i turchi ha preso il senso particolare di porzione riservata a ciascuno nel destino fissato da Dio. «Nei racconti e nelle credenze popolari, il Kismet appare come qualcosa di ineluttabile, che giustifica l’inerzia e al tempo stesso porta alla più completa rassegnazione alle sventure». A.A. V.V., Dizionario enciclopedico Treccani, Roma 1957, vol. VI, p. 569.
[12] A. DÖBLIN, La signorina dell’ospizio e la morte, cit., p. 42.
[13] Ibidem.
[14] Ivi, p. 43.
[15] Ibidem.
[16] E. A. POE, Racconti del mistero, dell’incubo e del terrore, Roma, Newton Compton 1993, p. 98.
[17] A. DÖBLIN, La signorina dell’ospizio e la morte, cit. p. 43.
[18] E. BANCHELLI, Prefazione, in A. DÖBLIN, L’assassinio di un ranuncolo e altri racconti, cit., p. 11.
[19] A. DÖBLIN, La signorina dell’ospizio e la morte, cit., p. 43.
[20] Ibidem.
[21] E. MORIN, L’uomo e la morte, Roma, Meltemi 2002, p. 70.
[22] A. DÖBLIN, La signorina dell’ospizio e la morte, cit., p. 43.
[23] H. STEGEMANN, Studien zu Alfred Döblins Bildlichkeit, Bern, Peter Lang 1978, pp. 97 – 100.
[24] A. DÖBLIN, Introduzione a L’assassinio di un ranuncolo e altri racconti, cit., p. 10.
[25] Come rivela la stessa moglie di Döblin annunciandone la morte in una lettera indirizzata ai coniugi Marcuse «nel primo diario – egli aveva circa sette anni – scriveva: “cos’è Dio?”». A. DÖBLIN, Briefe, München, DTV 1998, p. 501. La stessa conversione di Döblin al cattolicesimo avvenuta negli anni della maturità è stata spesso vista come repentino rovesciamento di posizione, come in contraddizione con la convinta asserzione del proprio ateismo sostenuta negli anni giovanili. In realtà, come spiegano numerosi studiosi tra cui Renzi, l’ateismo di Döblin non era intrinseco all’autore, fu la conseguenza dello studio di teorie scientifiche e non frutto di un’esperienza personale. Si dovrebbe parlare piuttosto, prendendo a prestito un concetto di Mauthner, di una Gottlose Mystik, una “mistica senza Dio”, termine di cui lo stesso Döblin si appropriò perché ben definiva il suo sentimento religioso il quale «senza ricorrere alla via trascendentale non lasciava intatta la questione sul mistero della vita». La lettura di letteratura esplicitamente antireligiosa, affiancata alla tendenza empirica peculiare di Döblin, contribuirono ad una certa scissione interiore, ad un’entrata in collisione dei presupposti ateistici con una religiosità intesa come processo, tentativo e percorso personale di ricerca.
[26] Un’interpretazione delle dinamiche storiche, culturali e letterarie interne al mondo dell’ebraismo mitteleuropeo nel volume di C. SONNINO, Esilio diaspora, terra promessa, Milano, Mondadori 1998.
[27] A. DÖBLIN, Das Ich über die Natur, Berlin, Fischer 1928, pp. 7 – 8.
[28] «Giacché la mia vita fu morte, sii tu, morte, la mia vita!». In traduzione italiana in H. HOFMANNSTHAL, Il folle e la morte, in H. HOFMANNSTHAL, Narrazioni e poesie, Milano, Mondadori 2001, p. 134.
[29] A. DÖBLIN, La signorina dell’ospizio e la morte, cit., p. 42.
[30] G. BATAILLE, L’erotismo, Milano, Es 1991, p. 11.
[31] Il termine “agonia” che in tedesco è Todeskampf, letteralmente “lotta della morte”, “contro la morte”, rende meglio che in italiano il senso di una lotta per la sopravvivenza.
[32] A. DÖBLIN, La signorina dell’ospizio e la morte, cit., p. 46.
[33] A. DÖBLIN, Reiseverkehr mit dem Jenseits, in A. DÖBLIN, Erzählungen aus fünf Jahrzehnten, Olten u. Freiburg/Br, Walter 1979, pp. 380 – 420. Per l’edizione italiana vedasi la traduzione di E. Arosio, in A. DÖBLIN, Traffici con l’aldilà, Milano, Adelphi 1997.
[34] Ivi, p. 21.
[35] A. DÖBLIN, Die Helferin, in Die Ermordung einer Butterblume, München, DTV 2001, p. 34.
[36] Ibidem.
[37] Ivi.
[38] Ivi, p. 35.
[39] Ivi, pp. 34 – 35.
[40] Ivi, p. 35.
[41] Ibidem.
[42] «Dann – erkrankte sie schwer. Er wußte keinen Weg zu finden, um zu ihr zu kommen , da ließ sie ihn, dem Tode nahe, rufen. […] sie fragte ängstlich, was mit ihr nach dem Tode geschehe. Er erzählte abgerissen, von dem Werden und Vergehen; irdisch sei alles an ihnen; sie blieben immer auf der Erde, denn in der Erde löse sich alles auf, um immer wieder zu wachsen in Regen Sonnenschein, Schnee, Kälte, Haß, Glück uns Leid und Liebe». A. DÖBLIN, Der Schwarze Vorhang, München, DTV 1987, p. 133.
[43] M. BLANCHOT, Il passo al di là, Genova, Marietti 1989, p. 70.
[44] L. RENZI, Alfred Döblin. Ricerca della verità, Padova, Messaggero 2003, p. 130.
[45] E. MORIN, L’uomo e la morte, cit., p. 119.
[46] «Nel senso di “stato di morte”, essa è del tutto e assolutamente inaccessibile a qualsiasi indagine psicologica. È infatti l’empirico non empirico, l’eliminazione di ogni comunicazione, l’annientamento di tutte le relazioni intramondane». AA. Vv., Dizionario di psicologia, Milano, Edizioni Paoline 1986, p. 708.
[47] A. DÖBLIN, Der Ritter Blaubart, in A. DÖBLIN, Die Ermordung einer Butterblume, cit., p. 68.
[48] A. DÖBLIN, Die Helferin, cit., p. 38.
[49] M. BLANCHOT, Il passo al di là, cit., p. 5.
[50] A. DÖBLIN, Berlin Alexanderplatz, cit., p. 486.
[51] A. DÖBLIN, Die Helferin, cit., p. 38.
[52] Ivi, p. 40.
[53] Ibidem.
[54] E. BANCHELLI, Prefazione, in A. DÖBLIN, L’assassinio di un ranuncolo e altri racconti, cit., p. 11.
[55] A. DÖBLIN, Berlin Alexanderplatz, cit., p. 500. Con questo vorrei ricordare che gli scritti di Alfred Döblin furono fra i tanti a essere bruciati nel rogo degli intellettuali considerati “eretici” dal regime nazista.
[56] Ivi, p. 40.
[57] Ibidem.
[58] Ivi, p. 41.
[59] A. DÖBLIN, La signorina dell’ospizio e la morte, cit., p. 46.
[60] A. DÖBLIN, Die Helferin, cit., p. 41.
* * *
Il Centro Sperimentale Pedagogico Tyche ricorda che tutti gli articoli presenti all’interno di questo sito possono essere liberamente consultabili e scaricabili. In caso di utilizzo del nostro materiale sarebbe onesto, nonché eticamente corretto, contattare gli autori e citare la fonte. Il Centro Sperimentale Pedagogico Tyche ringrazia e augura buona lettura.