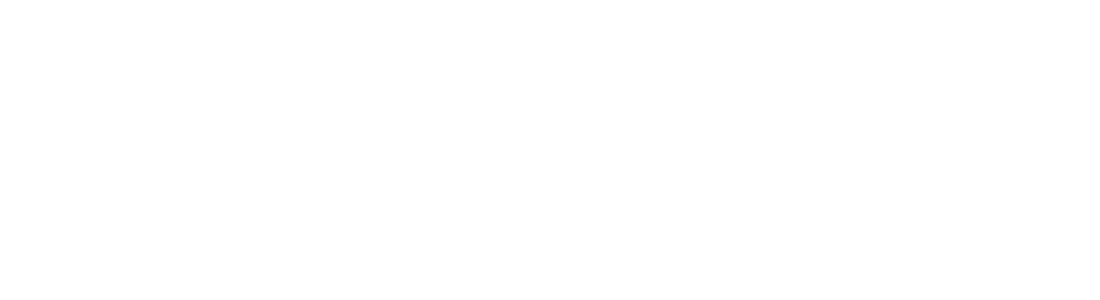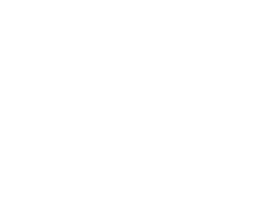Il Pedagogo, tra Maestro e Analista.
“Un valido motivo per fare un pò di silenzio…”
Di Pierluigi Sassetti
«Certo, non mi sembra che ci sia nessuno – almeno nel mio mondo, cioè nel mondo della cosiddetta cultura – che sappia minimamente apprezzare l’idea di compilare un trattato pedagogico per un ragazzo. Una tremenda volgarità fa pensare e accogliere tale trattato come una chiacchierata del tutto e perfettamente «leggibile». Va bene: vuol dire che invece di dedicarlo all’ombra mostruosa di Rousseau, lo dedicheremo all’ombra sdegnosa di De Sade».
(P.P.Pasolini)
«Tutto più semplice, se l’erba fosse commestibile».
(E. Bloch)
Sono diversi anni ormai che mi impegno nel tentativo di “traghettare” l’atto pedagogico all’interno del campo analitico fondato, a partire da Freud[1], da Jacques Lacan. Il mio intento è di circoscrivere questa pratica antica e insostituibile a un limite logico-operativo mirato all’assunzione di strumenti per la concretizzazione di un gesto etico, maggiormente incisivo e finalizzato; di prendere le distanze da una pedagogia “liberale-ortopedica”, “feticistica”, nonché “autoritario-materna”. Il motivo di questo mio interesse risiede nell’aver riconosciuto una povertà stilistica, una inefficacia di stampo perverso che impera in campo pedagogico e che conduce, in certi casi, ad una mancata decodifica di quei linguaggi che gravitano all’interno del rapporto con l’allievo; linguaggi che se da un lato rappresentano una ricchezza assoluta sulla quale operare, dall’altro costituiscono un eccesso rispetto al quale diviene importante sensibilizzarsi. L’atto educativo raramente lascia il segno o si mostra come radicale, per sopravvivere, invece, in una dimensione “vegetativa” all’interno di una realtà metodologicamente “qualunquistica”. Le cause della povertà stilistica del pedagogo e ciò che ne consegue può essere analizzato alla luce dell’insegnamento di Lacan approfondendo, mettendo a fuoco, tre diverse questioni analitiche, importanti per l’atto pedagogico perché riguardano il sapere e la modalità di farlo sorgere. Tengo a precisare, inoltre, che si tratta di un’ipotesi che necessita di una maggiore ed accurata elaborazione per potersi dire cristallina da un punto di vista logico-teorico, ma al tempo stesso è pur sempre un punto importante dal quale partire per creare un percorso di riflessione sulla figura del pedagogo e per la concretizzazione di una pratica educativa non tanto “possibile”, quanto etica e completamente dedicata alla causa del sapere: è una possibilità formativo-operativa affinché il pedagogo incontri il proprio Altro e riduca all’osso quelle pratiche ortopediche proprie della logica dell’Io che conducono inevitabilmente alla rimozione del sapere dell’Altro, per farlo invece emergere come fonte indispensabile di verità, un sapere dell’Altro da riconoscere in sé: come sapere.
La ped[a]gogia tagliente.
Lacan definisce l’inconscio come “taglio in atto” e la prima questione riguarda proprio l’inconscio, inteso come quanto non emerge all’interno dell’atto pedagogico sia a causa dell’intervento dell’insegnante potenzialmente perverso, che di un deficit conoscitivo che riguarda l’inconcepibile distanza del pedagogo rispetto al sapere psicoanalitico. «L’inconscio è il discorso dell’Altro»[2], chiarisce Lacan, fornendoci un’idea di inconscio lontana da una fantasiosa alchimia di ricordi e pensieri antichi, da un’oscurità magica, sperduta chissà dove nel mondo del soggetto: l’Altro è semplicemente ciò che sta fuori dal soggetto, includendolo. Si tratta quindi del mondo affettivo-passionale in cui l’uomo vive e si muove, che si origina a partire dal significante materno e successivamente quello paterno (S1, S2) per poi trasformarsi in una catena infinita di significanti che vanno a strutturare la grandezza dell’Altro. Il luogo in cui il soggetto si istruisce è appunto un significante, è quell’Altro scolastico in cui si fanno sentire le influenze dell’Altro sociale, nonché genitoriale. È quindi un luogo intriso così profondamente di dinamiche affettive che devono essere conosciute per fare dell’atto educativo un qualcosa di “autentico” ed affine al desiderio di colui che impara e conosce. Il soggetto parla il proprio Altro, a partire dal quale si significa, e, all’interno del campo pedagogico, questo Altro del soggetto si fa sentire fortemente al punto da determinare gli eventi, nel bene come nel male. È, infatti, questo rapporto che il soggetto tiene con il proprio Altro che può determinare favorevolmente, o viceversa in modo catastrofico, il percorso educativo. Per questo motivo l’inconscio ha valore anche in campo educativo, per il fatto che l’allievo, inevitabilmente, lo parla; ecco perché si rendono importanti nel pedagogo qualità “etiche” per la codifica dei contenuti inconsci mediante un ascolto di tipo analitico. Solo attraverso l’inconscio è possibile riconferire alla pedagogia quel “tagliente”, fondamentale per aprire gli occhi su di una necessaria “separazione” del soggetto rispetto al proprio godimento mortifero, per realizzare un sapere intriso del reale che incarna. Al di là dell’inconscio il sapere si renderà persistentemente vuoto di ciò che manca.
La trasparenza della perversione.
Sulla scia di quanto Lacan afferma, ovvero che «la perversione è l’essenza dell’uomo»[3], il secondo punto non potrà che riguardare questa questione analitica, da intendere non tanto come categoria clinica, bensì come una diffusa modalità di operare, una dimensione “invisibile” che danneggia perché gli elementi perversi presenti all’interno del mondo scolastico, nonché nella vita “polimorfa” dell’insegnante perverso, fanno da ostacolo all’inconscio, negano «l’esistenza dell’Altro»[4]. L’immaginario fantasmatico che l’insegnante perverso costruisce per non lasciarsi coinvolgere soggettivamente, finisce per offuscare le manifestazioni inconsce che l’allievo produce con un semplice e alquanto banale fine: mantenere il rapporto con lo studente all’interno di quell’immaginario necessario al fine di godere perversamente a livello personale-professionale. Se infatti l’allievo iniziasse a parlare, seguendo il proprio inconscio, al pedagogo resterebbe ben poco del proprio immaginario, finendo per fare i conti con quella frustrazione che è sintomo di un fallimento sia professionale che soggettivo. Ma all’interno dell’attuale mondo educativo, questo “evento” del “taglio in atto” si mostra assai raramente, in quanto l’allievo, in particolar modo l’adolescente, è oltremodo irretito nel discorso dell’Altro sociale e ne gode a tal punto da essere disposto a chiudere un occhio sulla perversione che subisce. Al tempo stesso, il pedagogo perverso, il “pedagodo”, usufruisce di un’istituzione troppo ben strutturata per temere il rischio di rimanere senza qualcuno di cui godere.
L’impasse pedagogica
Il terzo ed ultimo punto che rappresenta, secondo me, un’importante questione di arrivo-partenza dell’atto pedagogico è quello dell’oggetto piccolo a. E’ l’oggetto che attrae, che causa il desiderio: ciò che può coinvolgere il soggetto nel proprio operato, in quanto l’oggetto a, presente in lui fin dall’infanzia, conferisce all’oggetto che va a incarnare, quella forza pulsionale con la quale va a fare legame. L’oggetto a si trova all’interno dell’oggetto particolare, costituendo un centro di gravità fondamentale che arriva a coinvolgere corpo, pulsione e metafisica del soggetto, che si lascia parlare dal proprio desiderio. E’ il particolare che risiede in ogni persona, ed è ciò che fa la storia, che la costituisce là dove il soggetto riesce a non “cedere” rispetto ad una consapevolezza riguardante la propria particolarità.
Implico, in questa ricerca, una maggiore attenzione per la preziosità dell’oggetto a in quanto denuncio, nel quotidiano educativo che mi trovo ad analizzare, un radicale “scempio” a danno della particolarità del soggetto da educare. Riscontro, ovunque, un abbandono degenerativo della particolarità, una povertà in termini di forza e stile, un cedimento che rende la pratica educativa priva di singolarità, sia da parte dell’insegnante che dell’allievo. È questa una pedagogia del misconoscimento[5], una pedagogia senza forza né stile.
La domanda che pongo qui al pedagogo misconoscente può essere la seguente: in ambito educativo, interessa il particolare dell’allievo? E ancora: si può lavorare in educazione affinché il soggetto conosca la propria particolarità? Ma soprattutto, riferendomi con maggiore attenzione al pedagogo: hai qualcosa di particolare da parlare?
Voglio precisare, che con il termine “pedagogo” intendo isolare quel soggetto che si prende cura, da un punto di vista del sapere, di un qualsiasi altro individuo: insegnante, educatore, istruttore, maestro, counselor e via dicendo. L’assunzione, da parte di quest’ultimo, di un sapere psicoanalitico non è motivato da un fine clinico, in quanto non di competenza del pedagogo, ma dalla necessità di comprendere, mediante l’utilizzo di strumenti estranei al registro pedagogico, quelle dinamiche passionali che parlano il soggetto e che sono implicate all’interno del suo percorso educativo-esperenziale. Desiderio, “jouissance”, pulsione, reale, immaginario, simbolico, transfert, sono questioni lontane, da un punto di vista della trattazione, dal mondo pedagogico, in quanto nascono all’interno del campo analitico, ma finiscono inevitabilmente per avere un effetto all’interno del campo dell’educazione in quanto sono parte del discorso del soggetto. Operare con queste tematiche non significa voler fare del pedagogo un clinico, bensì una figura maggiormente sensibile alla questione che si nasconde dietro al “cogito”, all’«anima bella»[6] del soggetto da educare. Sensibilità rispetto al sintomo, ascolto, messa in gioco della propria questione soggettiva, sono tutte qualità che il pedagogo non può più permettersi di ignorare.
Dimensione etica e ascolto del desiderio.
Prendiamo spunto da un celebre aforisma di John Le Carré: «Quelli che possono, fanno. Quelli che non possono, insegnano»[7]. «Quelli che possono» costruiscono il proprio desiderio alla luce di un sapere specifico che diviene, nella pratica quotidiana, un importante strumento a partire dal quale la soggettività diventa atto; il linguaggio particolare (sapere specifico) viene usato allo scopo di ottenere la concretizzazione di un progetto personale, dal quale fluisce un sapere accumulato in anni di esperienza, esperienza realizzata mediante la pratica; un lavoro sui “segni” che ha origini antiche, risalente al momento dell’infanzia, in stretto contatto con i significanti paterni e materni. È questa la genesi di un Maestro puro, un soggetto che spinto da un motivante impulso pedagogico potrà far dono di un sapere reale, nonché di una necessaria disponibilità all’incontro. Un sapere lontano dalla nozione, dall’immaginario come dalla chiacchiera ed affine a chi, si presume, ne abbia fatto domanda.
Chi non possiede questa spiccata matrice soggettiva, cosa può donare all’altro? Il non averci saputo fare con il proprio desiderio implica la formazione di un educatore senza spiccate qualità, tendenzialmente incline al fallimento (personale) e che non potrà altro che riversare sull’allievo una complessa pedagogia perversa. Perché perversa? Perché indice da parte del pedagogo della negazione dell’esistenza di un desiderio proprio. Il perverso non conosce, o non ha saputo parlare, il proprio desiderio, per cui ciò che trasmette nell’atto educativo, rimanendo soggettivamente al riparo, è un atto privo di «stile»[8], potenzialmente vuoto, formale. «Quelli che non possono» quindi, i pedagoghi senza desiderio, instaurano una pratica dell’insegnamento quasi di ripiego, una “ortopedia” in cui la pedagogia scade in un rapporto perversamente passionale dove sulla scena si avverte l’assenza del linguaggio inconscio di colui che educa (in quanto non interrogato) nonché dell’allievo (perché non ne viene riconosciuto il valore e perché potrebbe infrangere quel precario immaginario dietro al quale il perverso si ripara).
Nel film Scoprendo Forrester, film di Gus van Sant (regista sensibile alle tematiche esistenziali dell’adolescente e al valore dell’educazione), questa doppia questione si mostra chiaramente: lo scrittore Forrester (interpretato da Sean Connery) dimostra chiaramente di parlare il proprio desiderio, creando una dimensione educativa che ammalia e cattura all’interno di un “mistero” l’adolescente inquieto e affamato di sapere. Forrester, scrittore di successo ritiratosi a vita privata, si mostra abile lettore del linguaggio adolescenziale, prevedendolo, ironizzandoci sopra in modo socratico, e alla fine smontandolo maieuticamente sotto gli occhi “frustrati” del proprio pupillo. Forrester ascolta la parola del ragazzo, tesse con lui un rapporto “simbolizzante” giocato tutto tra etica e amore pedagogico; l’aiuto dello scrittore è teso alla crescita letteraria (il desiderio del ragazzo), crescita ottenuta mediante una tangibile “localizzazione del godimento”, ovvero ponendo l’allievo di fronte al proprio desiderio, invitandolo a scegliere e conseguentemente a “perdere” del godimento per la concretizzazione del proprio progetto. La rinuncia al godimento va ad impreziosire quell’oggetto a che, nella vita del discepolo di Forrester, viene rappresentato dalla scrittura. Al tempo stesso, lo scrittore Forrester trova modo di riprendere contatto con la propria questione soggettiva a partire dalle “incursioni dialettiche” dell’adolescente suo discepolo, che, con domande che potremmo definire come dettate dall’ingenuità (ma in realtà motivate dalla pura volontà di sapere, dalla curiosità), va a toccare quei punti focali, “significanti” dello scrittore che si trova a rivivere un dolore sepolto. Forrester si lascia coinvolgere, uscendo dal calco immaginario nel quale si trovava, riparo confortevole ma al tempo stesso frustrante, offrendo agli occhi dell’allievo l’esempio di come egli, “soggetto supposto sapere” in quanto scrittore di fama mondiale, abbia ancora qualche conto esistenziale in sospeso con il proprio reale minaccioso e logorante.
Sull’altro versante, l’insegnante universitario (interpretato da F. Murray Abraham) che si prende cura “istituzionalmente” del ragazzo fallisce miserevolmente il suo mandato pedagogico per due circostanze: il primo fallimento è nei riguardi dell’allievo: il professore si taglia fuori dalla logica amorosa dell’incontro, ed in secondo luogo ignora la parola “desiderante” del ragazzo, non riconoscendo il talento e la passione con la quale questi si avvicina al mondo delle lettere. Tale insegnante, sul lato soggettivo, fallisce, dimostrando di essere fin troppo parlato dall’Altro istituzionale e scolastico, a discapito dell’agalma che ricopre di desiderio la parola rispetto alla quale si trova in una posizione di “fallimento misconosciuto”: egli ha ceduto al proprio desiderio fallendo nella realizzazione di un progetto personale (il desiderio di diventare uno scrittore al pari di Forrester).
Trovo significativo l’esempio pedagogico offerto da G. Klimt nell’occasione del primo, presumibile, incontro con il giovane E. Schiele. «Egon portò con sé qualche disegno e gli chiese se aveva talento: “Si”, fu la risposta ambigua di Klimt, “molto, troppo!”»[9]. Analizzando con attenzione un’apparentemente scarna risposta, possiamo invece ritrovare quanto detto fino ad ora: il «molto» rappresenta quel versante artistico che può riconoscere solo chi possiede altrettanta abilità o sensibilità per provare a far nascere nel proprio allievo una consapevolezza sulla grandezza del dono che possiede: Schiele aveva «molto» talento agli occhi del “Maestro” Klimt. Metto appositamente la parola “Maestro” tra virgolette in quanto intendo far riferimento alla figura del “Maître” che Lacan sostiene nella formulazione del suo Discorso del Padrone. Per Lacan il Padrone, l’antico padrone pre-capitalistico, può essere anche l’antico “Maestro”, ovvero una figura dai tratti marcatamente egemoni che si impone all’allievo con lo scopo di far sorgere in lui una forma di sapere. La figura di Socrate esemplifica perfettamente questa figura pedagogica. Klimt, in questo caso, parla da Maestro, “riconoscendo” nell’allievo un talento sintetizzato da quel «molto» che poi costituirà la grandezza di Schiele[10].
Completa la nostra analisi l’[A]ltra parte della risposta di Klimt, ovvero quel «troppo» che segue al «molto». Il «troppo», sempre secondo l’insegnamento di Lacan, è quanto si identifica con la questione del godimento, jouissance che coincide con l’eccesso. Tale eccesso, riconosciuto nel tratto pittorico del discepolo, viene avvertito da Klimt come un potenziale pericolo che, se non arginato, può arrivare a compromettere la vita artistica del novello pittore.
Mentre il «molto» è materia per il Maestro-pedagogo, che riconosce un talento prorompente nel tratto stilistico del discepolo, il livello estremo del talento che eccede, rappresentato dal «troppo», è una condizione del sapere che implica un’abilità più da “Analista” che da Maestro. Lacan ci indica, infatti, che l’analista possiede un dono etico formidabile, importante per raccogliere gli effetti di questo eccesso: l’analista ascolta. L’ascolto è una modalità di operare che nasce a partire da un prezioso e indispensabile silenzio così da offrire la possibilità, a colui che parla, di conoscere qualcosa di questo eccesso. Il linguaggio inconscio prende vita all’interno del discorso del soggetto, facendosi sentire mediante “effetti” che potranno diventare sempre meno ignoti agli occhi di colui che parla.
Che cosa avviene a questo punto? Là dove non sono presenti elementi clinici estremi di non competenza del pedagogo, è possibile lavorare sul godimento, sull’eccesso, renderlo “produttivo”, “localizzarlo”, per permettere all’allievo di “trovare” un’immagine di sé molto più autentica per il solo fatto di aver trovato qualcosa che, per effetto della passione dell’ignoranza, tentava assolutamente di misconoscere.
Il caso.
Come Freud ha insegnato, in psicoanalisi è indispensabile procedere per casi, confutare mediante la pratica quelli che sono i cardini teorici fondamentali. La pedagogia che va a inscriversi nel campo analitico necessariamente dovrà avanzare per casi, abituandosi a porre in questione il limite operativo sia come “impossibilità dell’atto educativo stesso”, che come indispensabile “ritorno” al campo analitico[11]. Chi segue “Notes Magico” saprà che la mia occupazione principale riguarda l’insegnamento della chitarra sviluppato mediante una formazione musicale didatticamente incentrata sulla psicoanalisi. In questa occasione vorrei presentare un caso in cui, ad un sapere specifico riguardante la formazione musicale richiesto dall’allievo, è subentrato un sapere psicoanalitico necessario per rendere chiara, da un punto di vista formativo, la domanda dell’allievo stesso.
Qualche anno fa mi si presentò un’allieva, che qui ribattezzerò con il nome di Gaia, una studentessa adolescente che possedeva già una valida preparazione di chitarra classica. Gaia, infatti, aveva studiato per diversi anni con un maestro che le aveva fornito non solo un’ottima preparazione tecnica, ma anche un repertorio di brani importanti. Fin dai primi colloqui preliminari, la ragazza mi era apparsa carente dal punto di vista dell’autostima, negando ogni mio elogio verso il proprio modo di suonare; con il trascorrere del tempo, notai in lei momenti di assoluta mancanza di motivazione, che rendevano il suo apprendimento discontinuo, pur rimanendo costante la frequenza alle lezioni. La invitai ad interrogarsi sui motivi di quella sua discontinuità ed emersero elementi sufficienti da convincermi ad interrompere le lezioni di musica per iniziare una serie di colloqui chiarificatori. Gaia iniziò a parlarmi del suo rapporto con lo strumento, raccontandomi i motivi che l’avevano indotta a iniziare a suonare, del padre indifferente alle richieste di avere una chitarra con la quale studiare, delle sue lezioni con il precedente maestro. Man mano che Gaia si raccontava, emergevano dal suo discorso elementi che mi inducevano a riflettere sul reale attaccamento della ragazza allo strumento. Gaia aveva ripreso quasi “meccanicamente” una strada già interrotta in passato, pensando di portarla a termine e ignorando un elemento che, mediante l’ascolto, ho potuto porre alla sua attenzione. Tra gli interessi di Gaia “risuonava” un’[A]ltra arte, l’arte della scultura, per la quale è stata disposta ad abbandonare la sua breve esperienza lavorativa e a rimettersi a studiare in una scuola di Stato ad orientamento artistico. La pietra, oggetto della scultura, è emerso come oggetto a della vita di Gaia, come cosa esistenzialmente antica che procura piacere nell’atto della manipolazione. La sua attrazione, definibile come erotica, verso l’oggetto della scultura, prende vita quando mi descrive minuziosamente il piacere che ricava nel veder emergere i tratti di tre volti da un blocco di alabastro da lei scolpito. Ho così diversamente impostato i nostri incontri, relegando la chitarra ad un ruolo marginale (cosa che un insegnante convenzionale non sa e non desidera fare) e lasciandole la libertà di rimetterla in gioco quando avesse voluto. Gaia è venuta così a capo del suo amore per anni “taciuto” verso la scultura recuperando quel sapere che comprende i traumi e quegli inganni affettivi sofferti nel periodo dell’infanzia e che hanno lasciato su di lei un velo di sofferenza evidente nella sua parola. La mia seconda mossa è stata quella di “localizzare il suo godimento”, permettendo a Gaia di interrogarsi su quelle “simpatiche dispersioni” che abbondano nella vita di ogni adolescente e osservando assieme a lei come la fuga di quel godimento potesse invece esserle utile per il suo principale scopo artistico. Eliminati così parte di quegli affluenti che tolgono forza ad un vero fiume in piena, ho sostenuto Gaia spronandola e riconoscendone il desiderio[12], permettendole di riflettere sui suoi cedimenti rispetto ad esso ed ascoltandone l’affanno che emerge per (ahimè) un rapporto frustrante per lei con i professori di scuola.
Conclusione.
Quali sono i rischi maggiori che si innestano al di sotto della logica razionale in cui troppe volte la pedagogia eccede? Come esemplifica il caso, insistere nell’insegnamento di un sapere, nel quale il soggetto tra l’altro eccelleva, poteva apparire la cosa più giusta da fare, ma cosa avviene se il desiderio dell’allievo si trova altrove, non coincide più con il sapere fino a quel punto appreso? Cosa avviene se, nonostante l’intervento dell’insegnante, l’allievo mostra palesemente di non possedere alcun interesse “gaio[13]”? Per un insegnante convenzionale, il rapporto con il discente può assumere i connotati di una “tragedia” solo per gli scarsi risultati ottenuti; il dialogo va a scadere “pedagogicamente” in quella interminabile sequenza di immagini narcisistiche che si riversano sull’allievo, per un “paradossale” bene educativo: l’insegnante rimprovera solitamente l’allievo di scarso impegno, di mancata applicazione, imprimendo così un “cogito” mortifero e aggressivo che contribuisce spesso ad allontanare ancor di più dal luogo del “fallimento”. L’allievo, dal canto proprio, imboccherà altre strade per soddisfare quel godimento immaginario proprio dell’adolescenza, senza farsi carico “edipicamente” di nessun peso che possa mettere in crisi il proprio percorso esperenziale.
Mediante la psicoanalisi è possibile mettere in evidenza come, alla fine di questo rapporto, insegnante e allievo si trovino entrambi di fronte ad un fallimento che deve essere assolutamente elaborato. Ma da un punto di vista tecnico, la questione del fallimento non è materia propria del Maestro, quanto dell’Analista come figura che per formazione sa fare i conti con il proprio insuccesso, permettendosi il lusso di trattenere quel sapere “frustrante”, di “sminuzzarlo” e comprenderne gli elementi che hanno concorso all’interruzione del rapporto con l’allievo[14].
Che cosa avviene a questo punto, nel momento della disfatta? Come due amanti delusi l’uno dall’altro, allievo e insegnante riprenderanno le proprie vite, cercando di rimuovere quel dispiacere avvertito in relazione al fallimento. Prende campo sulla scena la questione dell’ignoranza, del dover a tutti i costi misconoscere, la necessità di creare una distanza tra il soggetto ed il ricordo così da porre il sapere al centro della questione passionale: infatti per Lacan, l’ignoranza, al pari dell’amore e dell’odio, è una passione. È su questo punto che subentra il sapere dell’analista, come figura attenta non tanto all’ortopedia educativa, quanto alle questioni dell’anima di chi mostra tangibilmente di conoscere poco riguardo alla propria virtù metafisica. L’analista sa, per quanto paradossale possa apparire, che il fallimento è sempre un atto riuscito, al pari del successo, poiché il soggetto riesce a fallire sul piano razionale, proprio della logica dell’Io, per dare voce a quanto, potenzialmente, si agita nell’Altra scena, quella dell’inconscio. Per questo motivo è indispensabile mettersi nella posizione di elaborare quel fallimento che definisco come “prezioso” poiché può contenere tracce del desiderio taciuto del soggetto. Evento “didattico”, questo, che riesce raramente, per il quale è anche indispensabile un allievo decisamente “sensibile” al proprio sapere, che mostra già nell’elaborazione del proprio talento, una spiccata forma di indiscutibile “diversità”[15]. Il pedagogo, che va oltre la propria funzione di Maestro, abile al punto da non perdere l’allievo ai fini di un’ulteriore elaborazione di quanto avvenuto, dimostra un amore, un transfert significativamente maggiore, rispetto all’insegnante convenzionale che abbandona l’allievo sulla scia della frustrazione avvertita per gli scarsi risultati ottenuti. È come se l’insegnante smettesse di amare il proprio allievo per l’incapacità dimostrata, per aver frustrato quel senso narcisistico indispensabile che l’insegnante vuole e “deve” avvertire per aver formato un allievo così formidabile. Un pedagogo capace di ascoltare, sensibile ad un lavoro con il linguaggio inconscio, trattiene ulteriormente il discente in aula, gli permette di leggere qualcosa del proprio desiderio. Per questo tipo di pedagogo, come per l’analista, il fallimento è veramente un atto riuscito, portato a termine. È possibile, quindi, affermare la presenza di qualcosa in più del sapere in un rapporto pedagogico, qualcosa che non si esaurisce completamente nella dimensione educativa, identificabile nel desiderio di colui che opera, quale unico bene per l’allievo, unica risorsa per una consapevolezza rispetto al proprio desiderio.
Quando i pedagogisti parlano di ascolto, a quale tipo di ascolto fanno riferimento? La questione dell’ascolto, caritatevolmente di moda in ogni ambito educativo, di sostegno, di aiuto, reca in sé le stigmate di un “sentire” o di un “udire” che non porta a niente di buono, in quanto l’utilizzo della parola avviene sulla scia del godimento narcisistico e niente di più. Tale realtà legittima non una messa in gioco del soggetto in formazione, bensì una improduttiva chiacchiera per un inevitabile incremento del godimento all’interno della scena educativa. Quando invece si parla di ascolto, da un punto di vista analitico, viene sottintesa quella modalità “etica” che permette all’operatore di creare un punto di contatto con l’allievo, favorendo un indispensabile “ritorno” del sapere, del proprio linguaggio inconscio, che quest’ultimo parla. Ed è con questo “ritorno” al sapere del soggetto in formazione, che si rende chiara la grande modernità di un ascolto etico, sensibile rispetto alla logica “da decifrare” dell’Altro. Nella «moderna teoria della informazione […] non si può nemmeno parlare di codice dell’Altro: ora è appunto di quest’Altro che si tratta nel messaggio, perché è da questo che il soggetto riceve persino il messaggio che emette»[16]. E’ doveroso da parte del pedagogo venire a conoscenza di questo meccanismo, per non finire sempre con l’ignorare quanto accade nella comunicazione e per comprendere a partire da cosa il discorso si costruisce, così da rendere veramente “efficace” la parola non come “chiacchiera” bensì come “atto”. Ma è nel campo analitico che si trova la chiave per la decifrazione di una moderna rivitalizzazione della funzione del pedagogo.
[1] «Il mio «ritorno a Freud» significa semplicemente quello: che i lettori si accorgano di quel che vuol dire Freud, e la prima condizione perché se ne accorgano è che lo leggano sul serio. D’altronde ciò non basta: siccome una buona parte dell’educazione secondaria e superiore consiste nell’impedire alla gente di saper leggere, è necessario tutto un processo educativo per consentire a una persona di riimparare a leggere un testo. Bisogna pur riconoscerlo, una volta non si sapeva far altro, ma per lo meno lo si sapeva far bene». P. Caruso (a cura di), Conversazioni con Levi-Strauss, Foucault, Lacan, Milano, Mursia 1969, p. 135.
[2] J. Lacan, Il seminario. Libro XI, Torino, Einaudi 2003, p. 128.
[3] J. Lacan, L’ego di Joyce, in AA/VV, Ornicar?, Marsilio, Venezia 1979, p. 33.
[4] J. Lacan, Scritti, vol II, Torino, Einaudi 1974, p. 778.
[5] «Il misconoscimento – precisa Lacan – non è ignoranza. Il misconoscimento rappresenta una certa organizzazione d’affermazioni e negazioni alle quali il soggetto è attaccato. Non sarebbe dunque possibile concepirlo senza una conoscenza correlativa. Se il soggetto può misconoscere qualcosa, bisogna pure che sappia attorno a che cosa ha operato tale funzione. Bisogna pure che dietro il suo misconoscimento ci sia una certa conoscenza di ciò che deve misconoscere». J.Lacan, Il seminario. Libro I, Torino, Einaudi 1978, p. 208.
[6] «L’io dell’uomo moderno ha assunto la propria forma nella impasse dialettica dell’anima bella che non riconosce la ragione stessa del suo essere nel disordine che essa denuncia nel mondo». J.Lacan, Scritti, vol I, Torino, Einaudi, 1974, p. 275.
[7] Gino & Michele, Anche le formiche nel loro piccolo s’incazzano, Milano, Mondadori 1997, p. 129.
[8] «Lo stile è l’uomo» ci informa Lacan, precisando comunque, che l’uomo non è «più un riferimento sicuro». J.Lacan, Scritti, vol.I, Torino, Einaudi 1974, p.5.
[9] F. Whitford, Egon Schiele, Milano, Rizzoli Skira 2003, p.38.
[10] Un «molto» che non sembrò interessare a Griepenkerl, professore di Schiele ai tempi dell’Accademia, «regolarmente allarmato da ogni segno di ribelle originalità nei suoi allievi, forse perché aveva recentemente avuto come allievo Gerstl, un giovane straordinario, di abilità impressionante, morto suicida dopo il fallimento di una relazione con la moglie del compositore Schoenberg; inoltre Gerstl non sembrava voler emulare nello stile i livelli di perfezione tecnica su cui Griepenkerl insisteva tanto. Schiele e Griepenkerl non andavano d’accordo. Si racconta che una volta il professore abbia gridato al suo allievo: “E’ il diavolo che ti ha messo nella mia classe!”; e ancora “Non dire a nessuno, per l’amor del cielo, che io sono stato il tuo insegnante!». Ivi, p.37.
[11] Il pedagogo, non ha nessun campo al quale fare riferimento, così da non porre in discussione il proprio operato, condividendolo con altri colleghi e usufruendo di una supervisione, ed infine per rimettere in questione se stesso.
[12] Sostenere significa, da un punto di vista analitico, “riconoscere” il desiderio di chi parla sospinto dall’influenza del proprio Altro. Questa importantissima e al tempo stesso sottovalutata questione pedagogica, può essere sintetizzata, nell’operazione di riconoscimento che il pedagogo porta avanti nei confronti del proprio allievo, con le seguenti parole: “Io riconosco il tuo desiderio a partire dall’ascolto della tua parola, di ciò che in te si rende presente nella parola, sostenendolo e aiutandoti a conoscerlo e a servirtene”.
[13] «All’opposto della tristezza, c’è il gay sçavoir, quel gaio sapere che, lui si, è una virtù. Una virtù non assolve nessuno dal peccato, – originale come ognun sa. La virtù che designo come gaio sapere ne è l’esempio, manifestando in che cosa consiste: non: comprendere, punzecchiare nel senso, ma rasentarlo più che si può senza che faccia da vischio per questa virtù, e godere per questo della decifrazione, il che implica che il gaio sapere al termine non dia che la caduta, il ritorno al peccato». J.Lacan, Radiofonia Televisione, Torino, Einaudi 1982, p. 83.
[14] Il counselor all’Ascolto ad Orientamento Psicoanalitico, per fini formativi, è tenuto ad elaborare quei casi all’interno dei quali ha mostrato un palese “limite” del proprio sapere, ed è invitato ad elaborare tale limite all’interno sia del setting analitico che della supervisione, come nel lavoro di gruppo.
[15] «Si dirà che la gioia dell’avventura mentale è rara, che ci sono pochi che possono apprezzarla e che l’educazione comune non può tenere in alcuna considerazione un bene così aristocratico. […] Essa è molto frequente nei bambini e naturalmente si sviluppa dall’età del mito e della fantasia; inoltre essa diventa rara nella vita successiva, perché durante l’educazione si fa di tutto per distruggerla. L’uomo ha paura del pensiero più di tutto l’altro al mondo, più della rovina e persino della morte». B. Russell, Scritti sull’educazione (1916-1931), Treviso, Edizioni Canova 1977, p. 68
[16] J.Lacan, Scritti, vol. I, cit., p. 809.